Ho conosciuto Fontan nel 1976, a Firenze, quasi per caso, realizzando un desiderio che covavo da tempo. Allora, il 90% degli italiani che avevano frequentato la scuola dell’obbligo e godevano dei diritti civili, ignorava completamente che cosa e dove fosse l’Occitania. Perfino un linguista di fama come Tullio de Mauro chiamava la lingua occitana col nome di “provenzale”. I più colti intuivano che non si trattava di una malattia o di un gasteropodo e ipotizzavano che l’Occitania fosse uno di quegli staterelli balcanici, immaginari ma attestati dalla letteratura di consumo, quali, ad esempio la Ruritania del Prigioniero di Zenda o il Pontevedro della Vedova allegra.
Io, che ero curioso ma anche fortunato, invece, lo sapevo. Me lo avevano detto Fausta Garavini, che riusciva a insegnare anche letteratura d’oc all’Università di Firenze inserendola coraggiosamente tra le pieghe della letteratura francese e Osvaldo Coisson, un commerciante valdese di caolino, residente a Firenze, che aveva scoperto dieci anni prima, in patria, nella Val Pellice, di essere occitano e conosceva Fontan, in quell’occasione suo ospite.
In una situazione come quella, si capisce come conoscere di persona Fontan, che aveva scritto La nation occitane, ses frontières, ses régions pochi anni prima ed era il segretario del Partito Nazionalista Occitano in Francia e l’ispiratore del Movimento Autonomista Occitano in Italia, fosse per me un avvenimento eccezionale. Anche se non eravamo più di 10-12, in Italia, a sapere delle sue benemerenze.
Al contrario della parola “Occitania”, ancora ignota ai più, la parola “nazione” era ancora conosciutissima a Firenze e in Italia: solo che appariva universalmente intesa come sinonimo di “stato”. Il fatto che, per Fontan e per i suoi zelatori, esistesse una “nazione occitana” senza stato proprio ma con tutti i crismi per diventarlo, mi appariva straordinario.
Da quel poco che avevo appreso, ero ormai a conoscenza di questo fenomeno. C’erano anche ragioni più banali. Da bambino avevo letto di nascosto alcuni romanzi d’amore di mia sorella, narrazioni che possedevano una dimensione, sullo sfondo, anche politica, che mi avevano istigato a parteggiare apertamente, e con entusiasmo, per la causa irlandese e per la causa armena, due paesi di cui auspicavo la piena indipendenza nell’ambito di tutto il territorio dove si parlava la loro lingua. I romanzi si svolgevano infatti a Cork, sotto occupazione britannica e a Erzerum, sotto il tallone turco. L’eroina irlandese era stata strangolata dal suo amante inglese in un impeto di gelosia ingiustificata e l’eroina armena avviata con la forza sulla strada della prostituzione dall’ufficiale turco che l’aveva sedotta.
È ovvio che applicavo mentalmente a queste vicende drammatiche anche principi di giustizia e di democrazia generale: se la Gran Bretagna e la Turchia erano nazioni riconosciute in quanto stati, perché non dovevano esserlo l’Irlanda e l’Armenia, oltre tutto ferocemente oppresse proprio da loro?
Poi, da ragazzo, avevo preso l’abitudine di scrivere poesie ed ero eccitato dalle tecniche usate dai poeti. I Trovatori, col loro repertorio di coplas capfinidas, capdenals, retronchadas e capcaudadas e la loro abilità magistrale di entrebescar los moz (“intrecciare le parole”), mi avevano affascinato in maniera indelebile.
I trovatori scrivevano in occitano e questa lingua, data per estinta perfino su molti manuali, era invece ancora parlata, anche se da pochi, nella propria patria, come mi assicuravano Garavini e Coisson. E questo mi bastava per sposare la causa dell’indipendentismo occitano, di cui Fontan mi dicevano essere il teorico e il leader. Si può dunque capire come lo ammirassi e “bevessi” le sue parole: tra l’altro, dirò che lo incontrai a tavola, in un ristorante sull’Arno, un luogo delegato per mangiare e per bere: anche le parole.
Certo, quell’occasione, pur intensa, fu breve. Pochi giorni dopo, però, riuscii a procurarmi la seconda edizione di Ethnisme, vers un nationalisme humaniste, testo fondamentale del pensiero di Fontan, uscito l’anno prima. Entrai meglio in contatto col suo pensiero, così denso di spunti e di definizioni, che tuttavia mi sembrò, da un lato, meticoloso e pertinente, ma, dall’altro, distratto da esigenze che andavano oltre la “nazione” e l’“Occitania” per suffragare l’“umanismo” del titolo, cosa in sé lodevole ma forse di mole esagerata rispetto all’argomento trattato.
Non è un caso che Fontan abbia teorizzato, in seguito, che gli occitani erano sottoposti a tre alienazioni: nazionale (cioè linguistica e culturale); socio-economica (di classe); sessuale-generazionale (da cui il suo interesse per i giovani, con la formulazione del concetto di “classi di età”, importanti come quelle sociali, e le problematiche omosessuali, femministe ed ecologiche).
Le risposte a queste tematiche erano soltanto accennate nel libro, mentre quelle relative alla lingua erano sviscerate con sufficiente profondità. Certo, non si poteva fare di più in un libretto di appena 70 pagine, la cui bibliografia appariva, per giunta, per forza di cose, modesta e piuttosto parziale. Comunque, la definizione fontaniana della “lingua” come “indizio sintetico della nazione” era davvero calzante e felice.
Fontan sapeva moltissime cose ma non era uno studioso accademico. Era un animatore dal fascino enorme: e questo spiega i risultati della sua opera paziente ed itinerante che lo ha impegnato lungo una vita, tutto sommato, breve.
Fontan aveva le sue spiccatissime idiosincrasie e le sue predilezioni. A proposito di ogni lingua “nazionale” da costruire, sosteneva giustamente l’esigenza di una koinè, ma pretendeva anche che questa si basasse sui dialetti centrali del Paese in oggetto, quando esistono lingue codificate sulla base di dialetti periferici, perfettamente funzionanti. Il francese si fonda sul dialetto di Parigi e non su quello di Tours, l’inglese sul dialetto di Londra e non su quello di Birmingham. Pretendeva, poi, che tutte le lingue adottassero una scrittura alfabetica e un alfabeto fonetico, facendo torto a tradizioni che non andavano negate proprio perché “nazionali”.
Questo, per quanto riguarda le sue ribadite prescrizioni. Per l’individuazione di una lingua, riteneva poi necessaria l’intercomprensione tra coloro che parlavano uno dei suoi dialetti ed io ero, per esperienza, un feroce negatore di questo concetto. L’intercomprensione è un fatto culturale e non linguistico. Conosco un dialettofono ligure che dice, nel suo dialetto, gesgía, per “chiesa” e non comprende che cesa, in piemontese, significa la stessa cosa. Ma comprende subito il significato della parola church, che è inglese, senza che il ligure debba essere un dialetto inglese.
Fontan ha avuto scarso seguito in Francia, dove la pletora dei regionalisti, degli autonomisti e dei federalisti, che pure erano numerosi, non comprendeva ancora il significato reale della parola “nazione”, che continuava a identificare con lo stato, cioè con la Francia, nonostante l’ardore per la lingua d’oc. Fontan ha ottenuto invece un seguito di non lieve entità in Italia, nelle valli piemontesi che parlavano occitano senza saperlo, dove ha convinto un buon numero di giovani, parte dell’opinione pubblica e perfino le autorità regionali, naturalmente nei limiti di un costume irresoluto nel prendere provvedimenti, tipico della nostra classe politica.
Il suo messaggio rivoluzionario, pur negato in Francia dalla maggioranza degli occitanisti, è entrato, per merito suo, e soltanto suo, proprio nel cuore dell’occitanismo più militante che, pur negandolo, ha dovuto e deve confrontarsi con le sue enunciazioni proprio per negarle, alla vana ricerca di sostituti che sono soltanto antichi luoghi comuni (regionalismo, federalismo, autonomismo…).
In questo momento, i recenti “fatti” scozzesi, catalani e còrsi, che testimoniano l’inizio di una “grande fuga” dagli stati-nazione dell’Europa occidentale da parte di molte “nazioni senza stato” (come l’Occitania) sono un fenomeno significativo che gli stati attuali, pur travestiti da “nazioni”, non erano preparati (vedi il comportamento dello stato spagnolo nei confronti della Catalogna) ad affrontare ma che François Fontan aveva previsto con un anticipo visionario. Questo è il suo grande merito e il suo contributo prezioso alla storia in fieri dell’umanità. In questo senso, il suo “etnismo” può essere davvero un “nazionalismo umanista”, come lui credeva dovesse essere, e fornire la base più autentica per una società politica rinnovata e indotta al riconoscimento delle sue strutture di fondo.


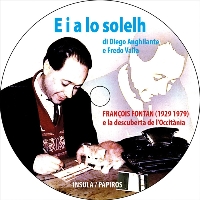
commenta